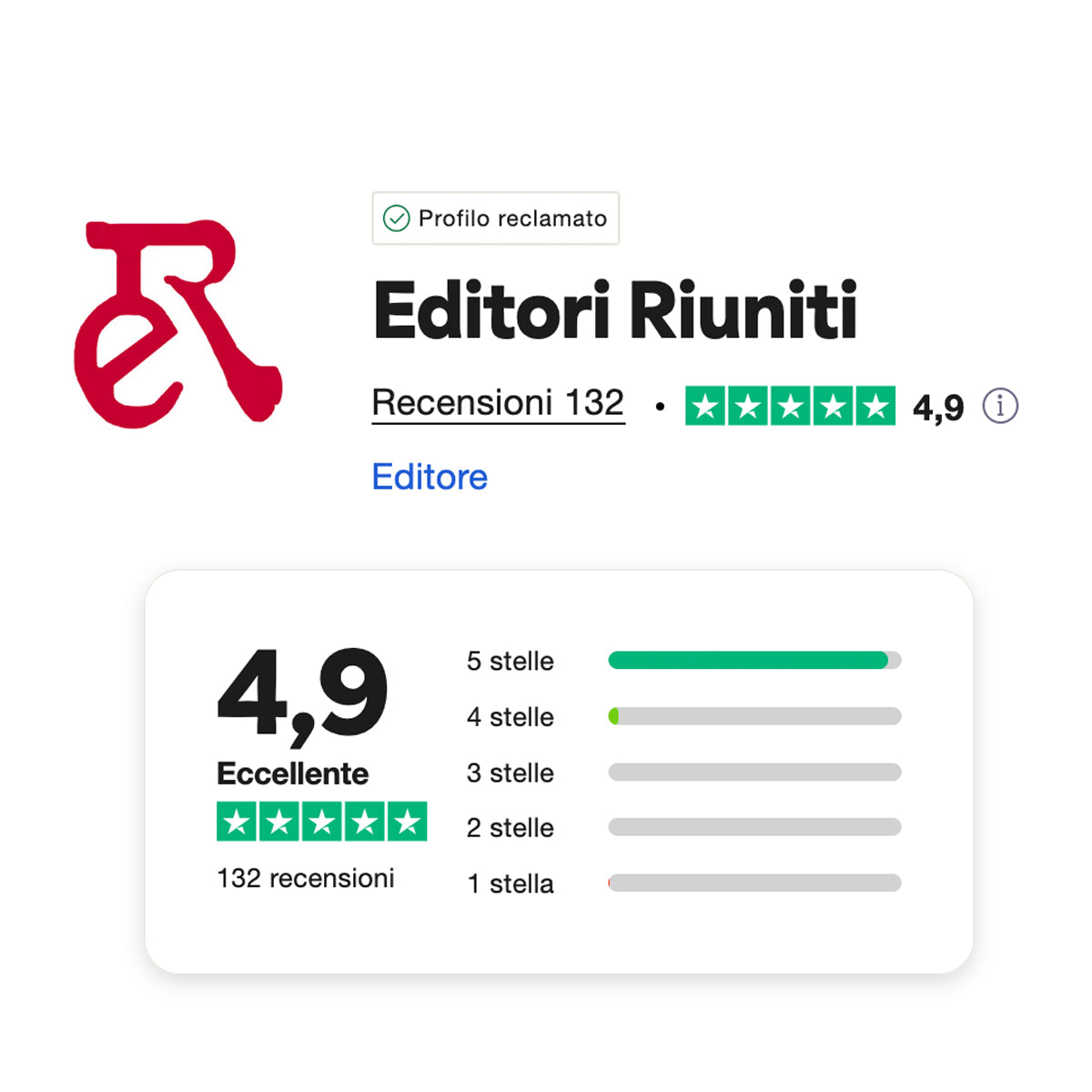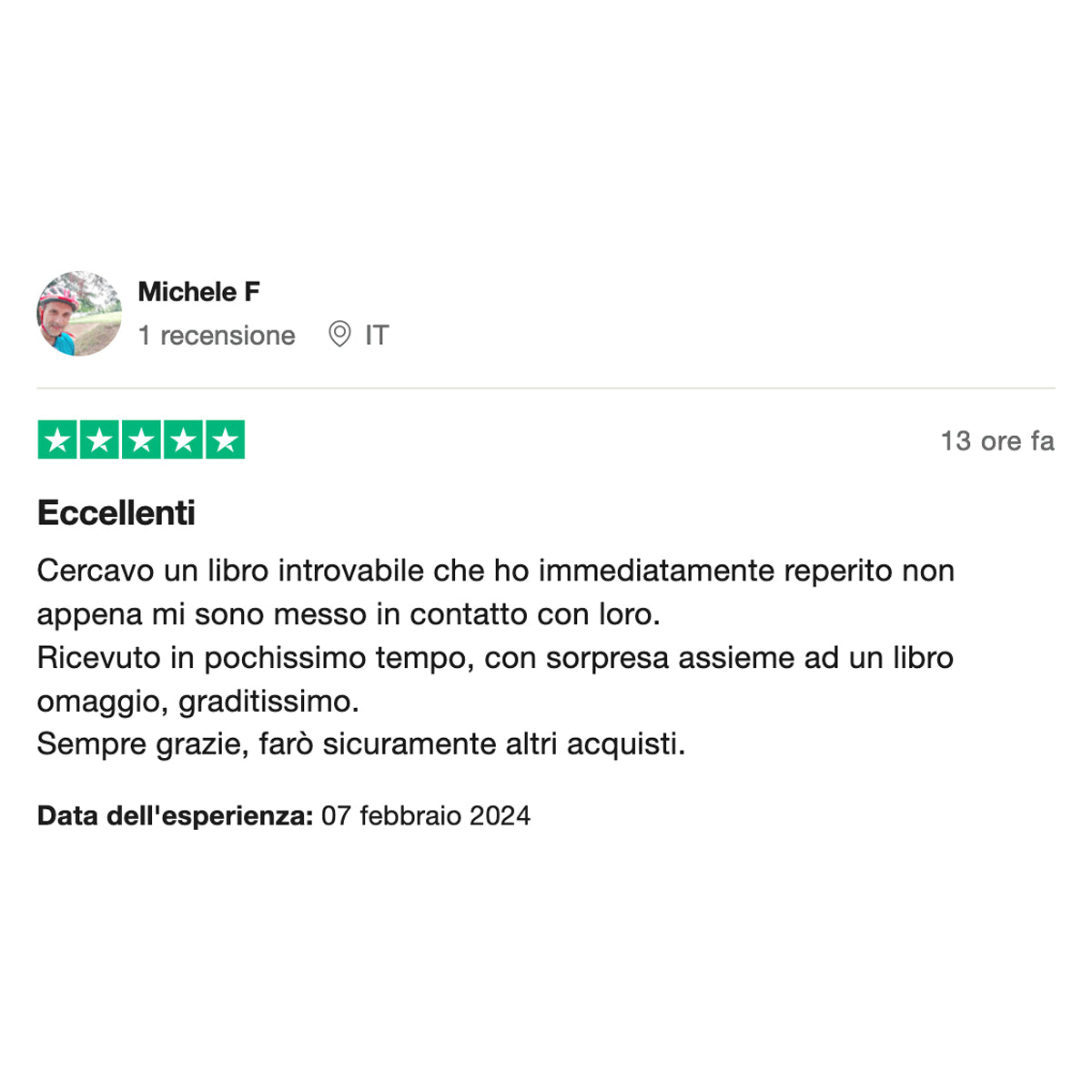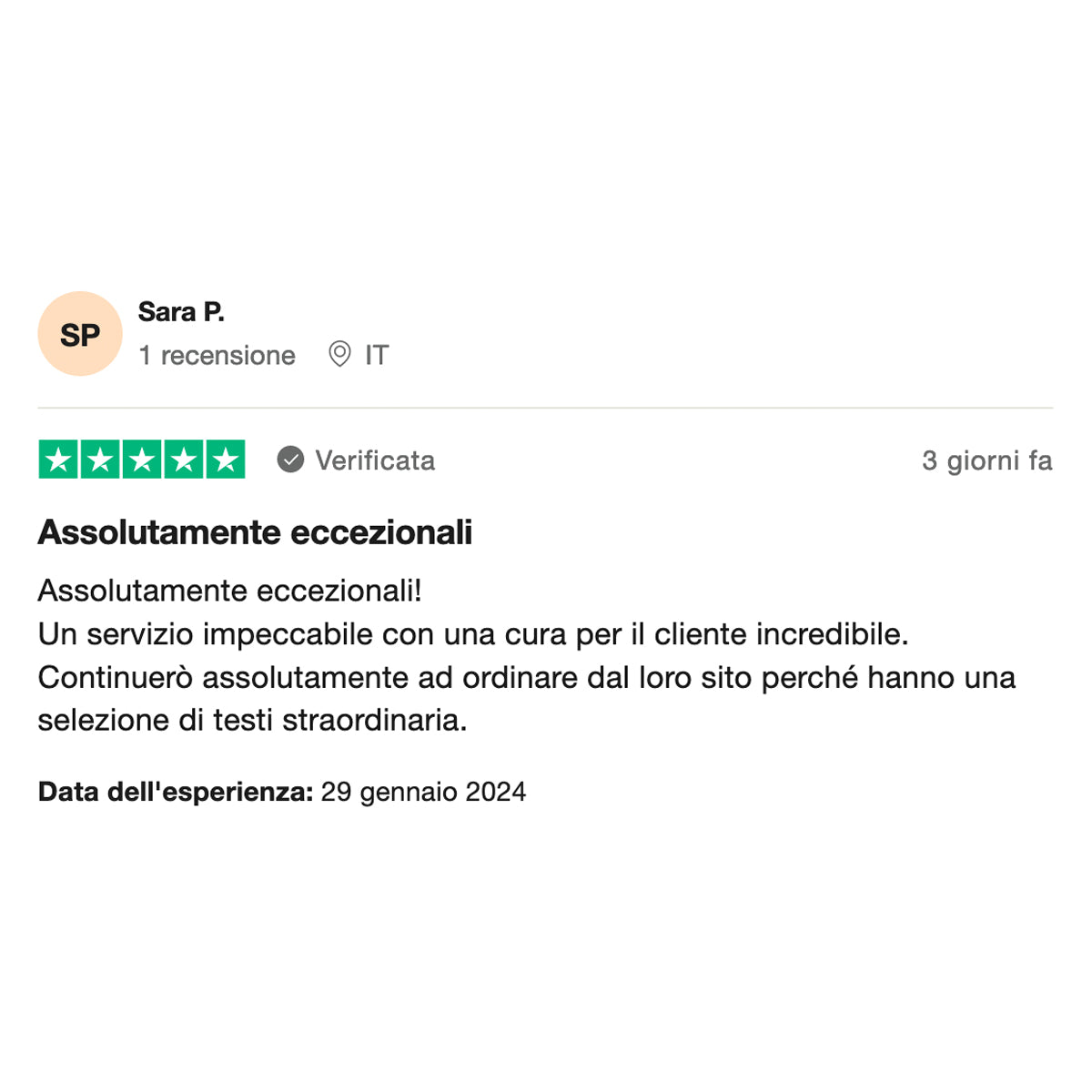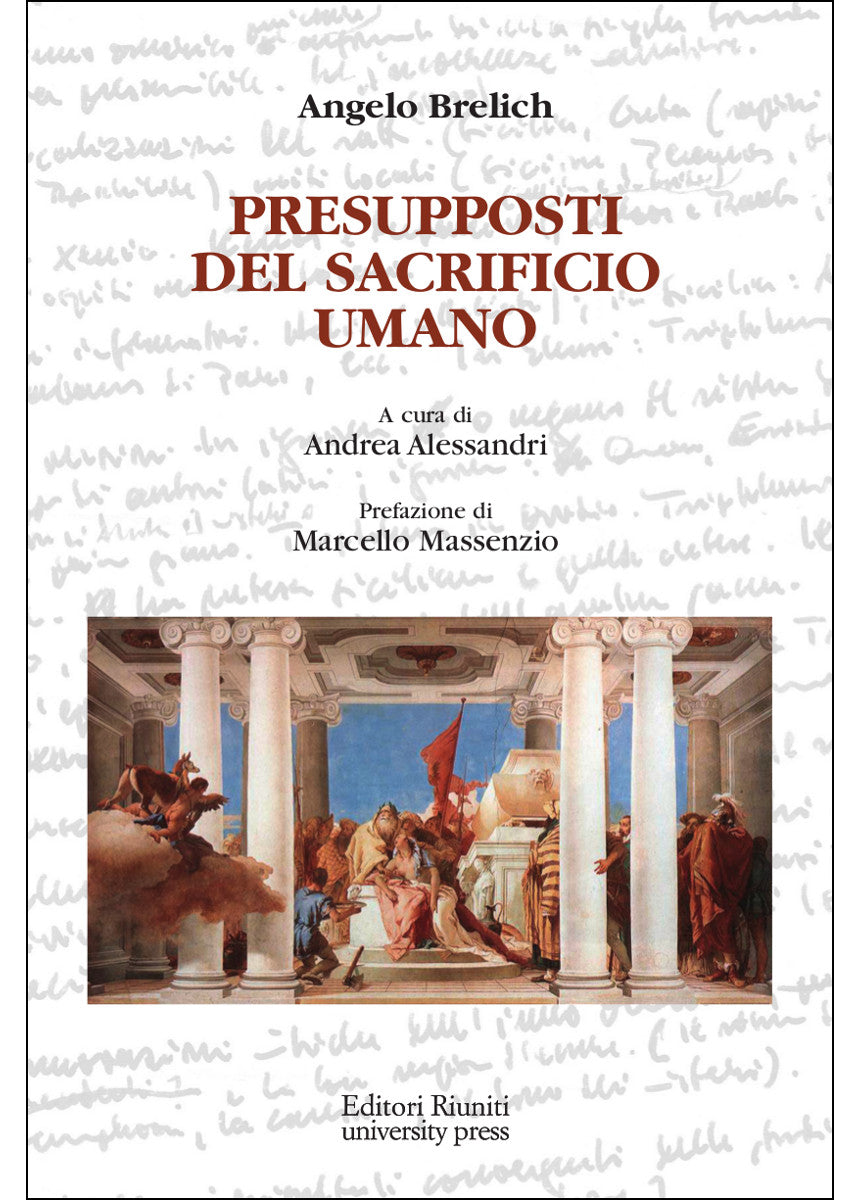
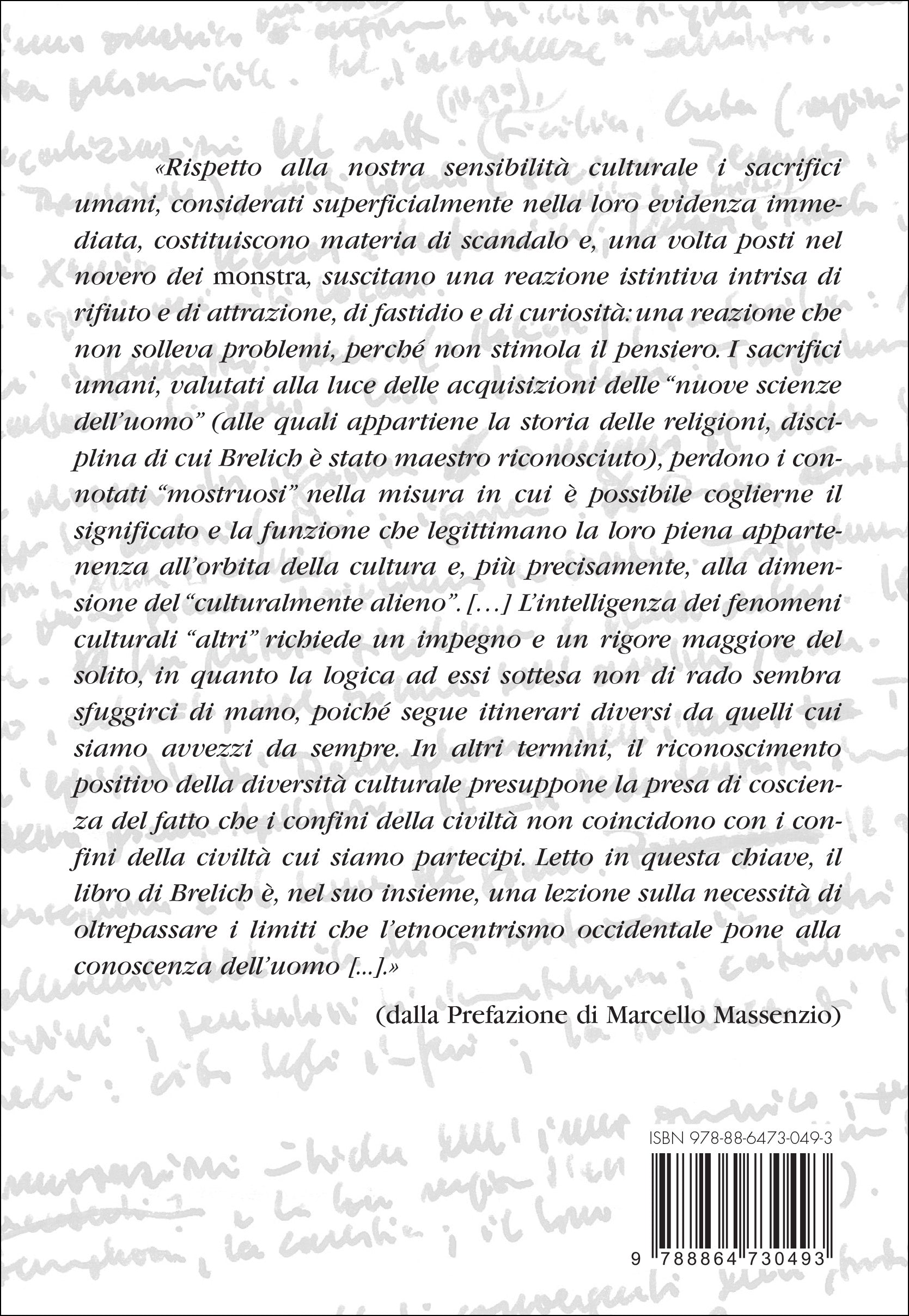
Angelo Brelich
Presupposti del sacrificio umano
Scegli le opzioni
«Rispetto alla nostra sensibilità culturale i sacrifici umani, considerati superficialmente nella loro evidenza immediata, costituiscono materia di scandalo e, una volta posti nel novero dei monstra, suscitano una reazione istintiva intrisa di rifiuto e di attrazione, di fastidio e di curiosità: una reazione che non solleva problemi, perché non stimola il pensiero. I sacrifici umani, valutati alla luce delle acquisizioni delle “nuove scienze dell’uomo” (alle quali appartiene la storia delle religioni, disciplina di cui Brelich è stato maestro riconosciuto), perdono i connotati “mostruosi” nella misura in cui è possibile coglierne il significato e la funzione che legittimano la loro piena appartenenza all’orbita della cultura e, più precisamente, alla dimensione del “culturalmente alieno”. […]
L’intelligenza dei fenomeni culturali “altri” richiede un impegno e un rigore maggiore del solito, in quanto la logica ad essi sottesa non di rado sembra sfuggirci di mano, poiché segue itinerari diversi da quelli cui siamo avvezzi da sempre. In altri termini, il riconoscimento positivo della diversità culturale presuppone la presa di coscienza del fatto che i confini della civiltà non coincidono con i confini della civiltà cui siamo partecipi. Letto in questa chiave, il libro di Brelich è, nel suo insieme, una lezione sulla necessità di oltrepassare i limiti che l’etnocentrismo occidentale pone alla conoscenza dell’uomo [...].»
dalla Prefazione di Marcello Massenzio